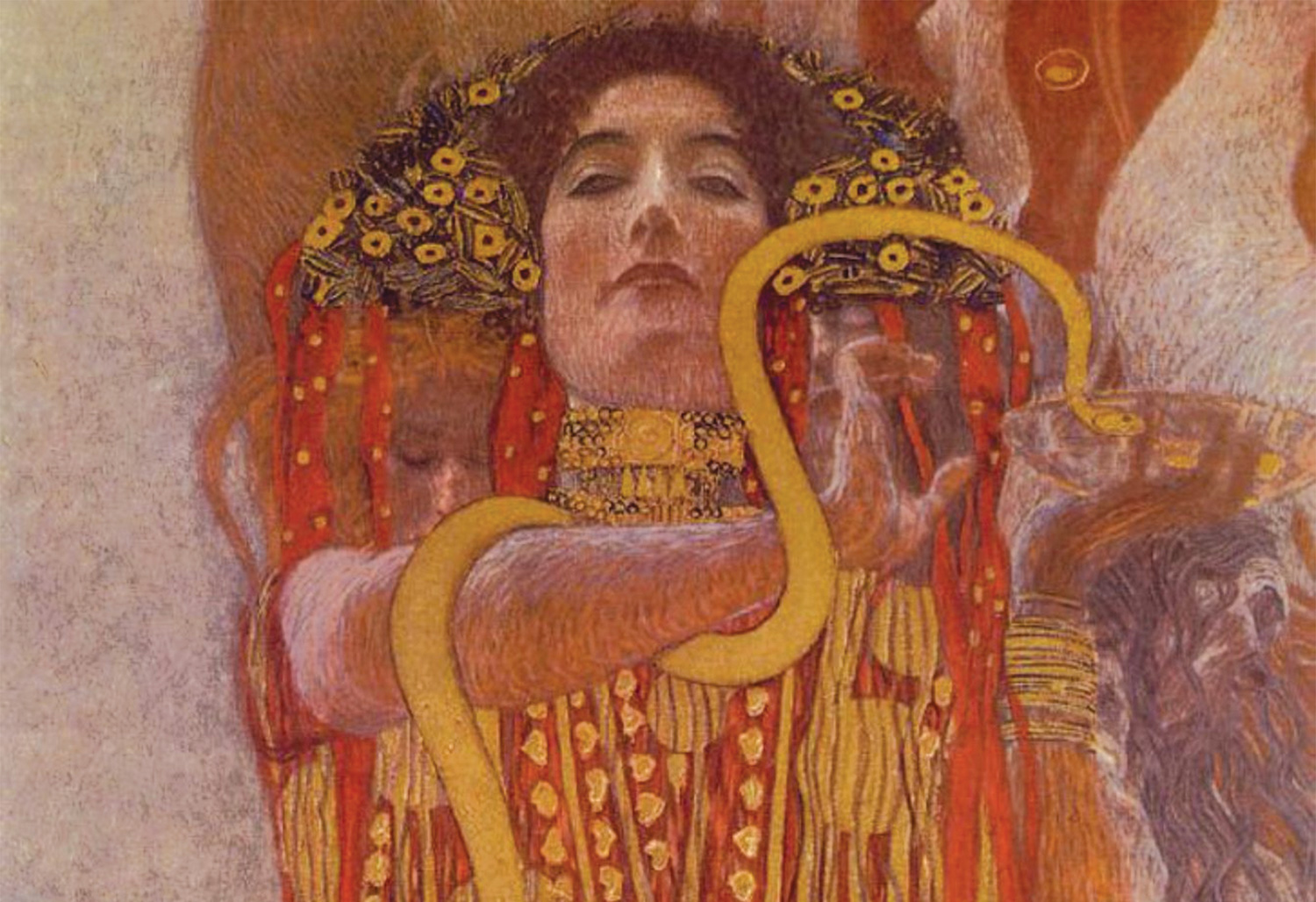Freak Art. Ripensare alla Shoah attraverso l’opera Personnes di Christian Boltanski

L’installazione “Personnes” (foto: Dider Plowy)
Chi ha acquistato il biglietto per Monumenta al Grand Palais parigino, tra il gennaio e il febbraio del 2010, era sicuramente preparato ad affrontare quel tipo di sollecitazioni multisensoriali che costituiscono il fondamento linguistico dell’arte contemporanea. Eppure, entrati nella parte dedicata all’installazione Personnes di Christian Boltanski, l’effetto di sorpresa e disagio ha accolto anche i visitatori più smaliziati.
La forma dell’installazione è nata nel Novecento, figlia dell’esigenza di estendere l’intervento dell’artista allo spazio reale della vita, al fine di creare un ambiente o una situazione in cui il fruitore viene messo di fronte a un’esperienza, più che a un’immagine o a un oggetto. L’arte contemporanea si indirizza a tutti i sensi dell’essere umano, non limitandosi più soltanto alla vista e andando ben oltre la peculiarità, da sempre intrinseca all’arte, di offrire l’immagine di una realtà alternativa.
Di fronte al visitatore di Monumenta che scendeva le scale all’ingresso del Grand Palais si mostravano cumuli di abiti usati stesi a terra, a formare degli isolati, tra i quali passeggiare come nelle strade cittadine, illuminati da lampioncini a rischiarare l’ambiente nelle ore serali. Attraversando questa prima parte, si giungeva di fronte ad un grande cumulo di abiti, alto decine di metri, sul quale svettava la benna di una gru, cui era affidato l’incessante compito di afferrare gli abiti dal mucchio, per poi lasciarli di nuovo cadere. A concludere la scena, lateralmente vi era una parete, formata da scatole di latta arrugginite, su ciascuna era stato inciso un codice numerico.
Descrivere a parole una installazione è difficilissimo, proprio perché la sua valenza comunicativa è affidata all’esperienza immersiva offerta al visitatore. Attraverso quella esperienza, l’artista attiva la suggestione che veicola il senso dell’intervento artistico. Prima di spiegare la finalità del lavoro di Boltanski, è importante considerare che l’artista contemporaneo si trova di fronte un fruitore molto “difficile”: siamo incessantemente immersi nella comunicazione multimediale e soprattutto digitale, che in qualche modo ha modificato la nostra capacità percettiva. Dal cosiddetto “effetto wow” che ci assale di fronte a una comunicazione innovativa (ricordate il primo approccio allo smartphone?) si passa velocemente all’assuefazione. Se l’artista vuole raggiungere le coscienze, deve mettere in atto azioni più incisive, in grado di penetrare a fondo, e questo riesce meglio se le sollecitazioni sono molteplici e multiformi.
Ecco quindi la necessità di affidare alla forma dell’installazione il compito di creare (o ricreare) un’ambiente in grado di sollecitare una risposta emotiva e culturale attraverso un’esperienza “guidata” della realtà. Non si tratta più di vedere l’opera, ma di viverla. A questo proposito, esortiamo i lettori a prendersi una pausa per andare a vedere il video documento dell’installazione al link: https://youtu.be/SXND1GZdBzM.
Le immagini evocate da Boltanski, in questo come negli altri suoi lavori, hanno a che vedere con la sua storia familiare: di famiglia ebraica, cresce in un clima legato al ricordo della Shoah, attraverso i racconti della madre, che salvò il padre dalla deportazione, facendolo nascondere per due anni sotto alle assi del pavimento. Il suo lavoro di artista parte quindi dalla creazione di una “mitologia individuale” che si origina dalla rielaborazione autobiografica attraverso la storia e la memoria collettiva. Nella memoria collettiva risiedono le immagini che hanno formato il bagaglio culturale della collettività, conservate in fondo alle coscienze e in grado di essere rievocate. Di fronte agli abiti usati gettati a terra, chi non ha ricollegato quelle tragiche immagini di oggetti ritrovati accatastati nel campo di sterminio di Auschwitz al momento della liberazione russa, che hanno fatto il giro del mondo? Le scarpe, gli occhiali, le scatole di latta con i pochi beni personali, di cui ogni prigioniero credeva di poter disporre ancora in futuro, hanno manifestato con forza agli occhi del mondo l’assenza di quelle persone che da Auschwitz non sono più tornate a casa. Così gli abiti usati di Boltanski, che rivelano l’assenza di tutti i loro proprietari: quelle “Personnes” (=persone) che diventano “personne” (=nessuno).
Rivelata la chiave di lettura dell’opera, potete continuare da soli il percorso di decodifica interpretativa: si dovrà attingere all’archivio mnemonico delle immagini relative all’evento tragico della Shoah, tante volte viste - anche di sfuggita – attraverso i media, ma tuttavia registrate dal nostro cervello. La corrispondenza fluisce libera: allora, gli isolati formati da abiti ricordano la disposizione regolare delle baracche nel campo, realizzata attraverso un’organizzazione architettonica che rispondeva a un’esigenza di massima funzionalità e dove lo sterminio di esseri umani divenne una faccenda da sbrigare nella maniera più efficiente possibile, attraverso l’impiego di tecnologie avanzate. Allora, le scatole di latta arrugginite col numero impresso non possono che ricordare il “marchio”, applicato all’ingresso del campo con tatuaggio indelebile, destinato a sostituire l’identità di ogni prigioniero. Allora, la benna della gru che solleva gli abiti come corpi senza vita, ridotti a esili fuscelli dagli stenti patiti, allude alla meccanizzazione dello sterminio, attuata per la prima volta con una fredda logica industriale. L’individuo, privato della libertà, dell’identità, della salute, della proprietà non ha diritto neppure ad essere ucciso da un altro uomo, ma viene “smaltito” da un sistema di morte automatico (le docce e i forni…) come un rifiuto da eliminare. Il percorso del visitatore tra gli elementi dell’opera d’arte è quindi un percorso verso la memoria, rievocata attraverso un’esperienza immersiva, riproposta e guidata dall’artista. Il collegamento avviene grazie alla sperimentazione individuale di una situazione e il messaggio risulta così più incisivo, perché guadagnato da ciascuno e piegato alla propria sensibilità.
Il vociare dei visitatori di Monumenta si faceva spontaneamente sommesso, fino al silenzio, mentre si aggiravano dentro l’opera di Boltanski: solo il rumore meccanico della benna inesorabile si sovrapponeva alla percezione dell’odore acre e pungente degli abiti gettati in terra. Ma facendo attenzione, a tratti un suono ovattato riempiva l’aria con cadenza ritmica: la colonna sonora dell’installazione di Boltanski era la registrazione di innumerevoli battiti cardiaci – segno distintivo dell’unicità di ogni essere umano – raccolti fin dal 2005 dall’artista nel suo Les Archives du Coeur, con sede nell’isola di Teshima (Giappone).
Qui si completa il cerchio delle suggestioni: se gli abiti alludono direttamente alle spoglie mortali, facendo riflettere sulla fragilità umana e sull’ineluttabilità dello scorrere del tempo, essi conservano però tracce delle vite che hanno contenuto, impronta del corpo e dell’anima di coloro che li hanno indossati, come il suono del battito del loro cuore. L’unicità e l’identità dei singoli individui è una traccia indelebile che viene conservata dalla memoria ma anche dagli oggetti che sono stati a contatto con quella persona.
L’opera di Boltanski venne esposta anche a Milano presso il Pirelli Hangar Bicocca, nell’estate successiva (giugno-settembre 2010). Al termine dell’esposizione, come spesso succede, l’opera è stata “dispersa”: ciascun visitatore poteva portare via alcuni abiti per donare loro una nuova vita.
(Manuela Marsili)